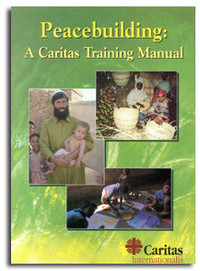La Chiesa tra i due fiumi
Baghdad, gennaio 1998. Dopo avere oltrepassato il confine giordano con un visto rilasciato ad Amman, si corre per il deserto per circa un migliaio di chilometri con uno dei tanti taxi che fanno la spola tra la Giordania e l'Iraq, non essendovi la possibilità di arrivarvi con l'aereo. I due aerei iracheni fermi sulla pista di Amman, ormai corrosi dagli agenti atmosferici, sono quanto mai espressivi. Non v'è dubbio che il deserto sia affascinante, anche quando ci si imbatte in violente bufere di neve e il vento grida nel silenzio delle dune.
Si ha tutto il tempo di riflettere, perché la strada è lunga, interminabile e con il taxista, che biascica qualche parola d'inglese, non è che si abbia voglia di continuare a lungo a chiedere come vanno le cose in Iraq. Si ha tutto il tempo di ricordare la guerra di sette anni fa, oggi che nuove tensioni tra Stati Uniti e Saddam Hussein lasciano aperta la possibilità di un nuovo scontro. Si ha il tempo di guardare e vedere la situazione di miseria in cui versa il paese.
Baghdad rimane una città splendida. Fascino di numerose palme e suggestione di ponti sul Tigri. Ma ci si imbatte subito anche in ragazzini che chiedono l'elemosina, in gente che vende uccellini in gabbia, persino cagnolini e gattini, e in tanti che espongono frutta e si divincolano per fermare i passanti.
Questa gente ha ben poco da mangiare, quasi niente. Il governo ha stabilito le quote mensili di grano, riso, zucchero, thè, sapone e per i bambini due chili e mezzo di latte in polvere. Questo maledetto embargo costringe alla denutrizione e alla morte tanti e tanti bambini ogni mese; ammazza i vecchi e spinge i giovani a lasciare prestissimo la scuola per andare qua e là a procurasi da mangiare per la famiglia. Contro l'embargo sentirò parole di fuoco da parte di tutti: dal nunzio, diplomatico capace e coraggioso, ai vescovi delle chiese, che forse potrebbero dimostrare un po' più di determinazione nel sostenere la posizione ribadita dal papa nel suo recente discorso al corpo diplomatico (cf. Regno-doc. 3,1998,80).
Devo dirmi fortunato per avere trovato alloggio nel seminario maggiore caldeo di Baghdad, dove confluiscono studenti di filosofia e teologia avviati al sacerdozio. Con loro ho trascorso alcuni giorni conversando, chiedendo, vergognandomi per quella guerra che sette anni fa annientò una nazione, per dare una lezione al dittatore Saddam. Diversi osservatori esteri ritengono che allora Saddam si sia lasciato ingannare dagli americani, i quali gli avrebbero lasciato intendere che, nel caso di una sua invasione del Kuwait, essi non sarebbero intervenuti. Sappiamo come sono andate le cose.
Ho maledetto quel missile "intelligente" che il 14 febbraio 1991 colpì il rifugio nella zona di Amirya, perché ho visto che cosa ha provocato: il massacro di oltre mille persone. Una donna vestita di nero, che ha perso tutta la famiglia, mi racconta quel giorno. Foto, immagini, volti di bambini, giovani, famiglie intere e una croce per ricordare... A sette anni da quella guerra, ho varcato la soglia del rifugio e ho ascoltato le parole spezzate dal pianto di una mamma. Vi fosse stato anche un solo bambino morto, quella guerra assurda dovrebbe pensarci anche come chiesa, a pochi giorni dal grande giubileo dei cristiani.
Assiri. I non cattolici della chiesa d'oriente, un tempo denominati nestoriani, sono il 7% dei cristiani. Hanno un metropolita per tutto l'Iraq e un vescovo senza poteri, un seminario – i cui studenti frequentano il collegio di Babel–. Una parte della chiesa assira è nata alla fine degli anni sessanta, ha un patriarca residente a Baghdad e raccoglie il 10% degli assiri.
Siri cattolici. Sono il 7% dei cristiani, con due arcivescovi per tutto l'Iraq.
Siri ortodossi. Sono il 7-8% dei cristiani, con due arcivescovi, a Baghdad e a Mossul, un vescovo nel monastero di Mar Matta e un altro che insegna nel seminario di Mossul.
Armeni ortodossi. Sono il 3% dei cristiani con un arcivescovo per tutto l'Iraq.
Latini. Sono circa 3.000 con un arcivescovo a Baghdad, Paul Dahdah ocd, dal quale dipendono i domenicani, i carmelitani, le suore catrinette, le suore della Presentazione, le missionarie della carità e anche in parte i redentoristi e le piccole sorelle. I domenicani dirigono la rivista Pensiero cristiano e un corso teologico molto frequentato dai laici. Parecchi padri latini insegnano nel collegio di Babel.
Altri. Protestanti (luterani e avventisti), greci ortodossi, armeni cattolici, greci cattolici, copti.
Il papa ha voluto dire che anche all'interno del paese ogni sforzo va fatto per trovare strade più percorribili; in parole semplici: attenzione a non infiammare gli animi dando vita a esplosioni incontrollate.
Anche Saddam ha gravi responsabilità verso il suo popolo.
A Baghdad (un po' meno nelle altre zone, mi è stato detto) si ha l'impressione di vivere in un territorio senza identità, in balia di avvenimenti imprevisti, di illusioni paranoiche, alla ricerca di continui espedienti per sopravvivere. Ai lati delle strade, nei mercati all'insegna del nero, la gente è in bilico tra la vita e la morte, vende quello che ha di più caro, dagli oggetti di casa ai ricordi. Mercanti senza scrupoli arricchiscono sulla pelle di chi non ha più speranza e ingannano con viaggi inumani attraverso il deserto o le montagne, verso la Giordania o la Turchia, alla volta dell'occidente.
Quanto raccolto in questo reportage dalla terra dei due fiumi guarda alla situazione della chiesa, al suo futuro incerto e alle condizioni di un popolo, al quale è stata imposta la povertà e che si vorrebbe annientare per sfruttane le ricchezze della sua fertile terra e del sottosuolo, gonfio di petrolio. Un giovane mi dice: "Siete dei criminali voi occidentali".